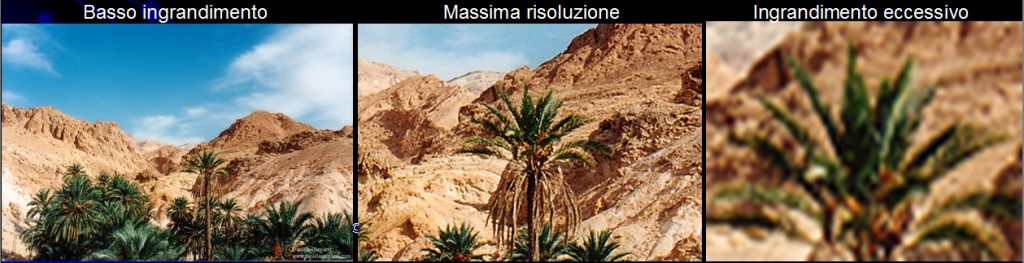E’ la domanda più classica di tutte, che mi viene fatta spesso. Invece di rispondere privatamente uno per uno ripetendo, alla fine, sempre gli stessi concetti, ecco qua qualche consiglio spicciolo per acquistare un telescopio.
Il primo consiglio è di essere consapevoli. Acquistare un telescopio è solo il coronamento di un percorso di apprendimento del cielo che deve essere già stato fatto. Sappiamo riconoscere le costellazioni? Sappiamo cosa aspettarci dall’osservazione al telescopio? Abbiamo già usato un binocolo? Se la risposta è no, allora facciamo un passo indietro necessario per evitarci cocenti delusioni. Acquistiamo delle carte celesti, o scarichiamoci qualche app di simulazione del cielo, cominciamo a riconoscere le costellazioni, la stella polare, a capire come si muove il cielo. Acquistiamo un binocolo astronomico, magari un 10X50, e iniziamo a fare pratica con questo, perché le cose che potremo vedere saranno molte e già spettacolari. Frequentiamo un’associazione astrofili, che ci farà provare diversi ottimi telescopi e alla fine saremo pronti per il grande salto.
Approfondiremo questi singoli argomenti (il cielo a occhio nudo e con un binocolo) in altri post, perché qui assumiamo che il cielo lo conosciamo e siamo in grado di fare una scelta consapevole.
Ci sono delle domande che dobbiamo porci per acquistare il primo telescopio, con la consapevolezza che non esiste lo strumento ideale che faccia tutto in modo perfetto:
- Quanto sono disposto a spendere? Un telescopio è uno strumento di precisione, non un giocatolo, che quindi ha un costo. Se siamo disposti a spendere diverse centinaia di euro per uno smartphone che dovrà essere sostituito dopo un paio d’anni, perché non spendere qualche centinaio di euro almeno per il primo telescopio che può durare una vita? Uno smartphone per andare su Facebook merita davvero un budget maggiore di un telescopio che ci farà esplorare l’Universo? Detto questo, il budget minimo dovrebbe essere sui 200-300 euro. Sotto questa cifra compreremo solo dei costosi giocattoli;
- Da dove osservo? Molti oggetti celesti hanno bisogno di cieli scuri. Se ci troviamo in città non potremo mai sperare di osservare galassie, nebulose e ammassi stellari in modo soddisfacente, quindi sarà inutile comprare un telescopio ingombrante e in teoria potente, quando la grande luce della città non ce lo farà mai usare bene;
- Cosa voglio osservare principalmente? Pianeti e Luna, magari anche qualche ammasso stellare, oppure oggetti del cielo profondo come galassie e nebulose?
- Devo spostarmi per cercare un cielo scuro? Se sì, allora meglio non comprare un telescopio lungo più di un metro che non entra nella nostra utilitaria;
- Vorrei fare delle foto serie in futuro, al di là di qualche scatto alla Luna?
Quante domande! Nessuna paura, adesso facciamo chiarezza, magari iniziando con qualche consiglio utile:
- Se il budget è limitato a poche centinaia di euro, meglio non scegliere un telescopio computerizzato perché per mantenere basso il prezzo bisogna sacrificare la potenza ottica. E cosa ce ne facciamo di un’elettronica che trova gli oggetti, se poi il telescopio non ce li fa vedere? In altre parole: se la coperta è corta meglio dare spazio al diametro e meno all’elettronica. In ballo ci sono centinaia di euro di differenza tra uno strumento “manuale” e uno stesso dotato di elettronica, che però hanno la stessa “potenza”;
- Il mercato propone strumenti già pronti, qundi equipaggiati di treppiede, montatura e telescopio, ma questo non toglie che noi possiamo creare lo strumento che vogliamo acquistando a parte montatura e tubo ottico.
- Per fare fotografia astronomica attraverso il telescopio serve necessariamente una montatura equatoriale che spesso costa molto più del telescopio stesso. Le montature equatoriali che equipaggiano gli strumenti di piccolo diametro saranno adeguate per fare qualche scatto ai pianeti attraverso lo strumento o per fare foto a grande campo senza usare il telescopio, a patto di motorizzarle in ascensione retta. Non serve il puntamento automatico e non bisogna usare montature altazimutali. Non acquistiamo quindi il primo telescopio sperando di poterci fare splendidi scatti a nebulose e galassie, ma al limite solo per iniziare a imparare i rudimenti della fotografia astronomica, che rappresenta uno step successivo e molto più costoso.
Bene, adesso passiamo ai consigli più mirati, tenendo presente che queste sono indicazioni di massima e fatte sulla base della mia esperienza.

Un rifrattore acromatico da 90 mm su una piccola montatura equatoriale: un ottimo inizio per Luna e pianeti
Per osservare pianeti e Luna, anche da cieli non bui come quelli di città e pianura, e magari avere la possibilità, in futuro, di fare qualche foto, ci serve un telescopio su montatura equatoriale. Lo strumento ideale è un rifrattore acromatico o un Mak da 90 mm (meglio 127 ma saliamo di budget) su una montatura equatoriale almeno EQ3-EQ3.2 (o NEQ3). Questa configurazione sarà poi personalizzabile in futuro. Si potrà scegliere di cambiare il tubo ottico con uno più potente, visto che una EQ3 può reggere bene, in visuale, anche strumenti più potenti come il classico C8, uno Schmidt-Cassegrain popolarissimo. Si potrà scegliere di aggiungere la motorizzazione e persino un GOTO (puntamento automatico). La montatura, poi, potrà essere usata anche come base per fare fotografia astronomica con obiettivi fino a 300 mm di focale o piccoli telescopi da 60-70 mm di diametro, dotandola anche solo di un semplice motorino, molto più economico del GOTO.
Per capire la differenza tra uno sturmento con elettronica e uno della stessa “potenza” ma senza elettronica, qui c’è un rifrattore da 90 mm manuale su una piccola montatura equatoriale che potrà essere motorizzata per pochi euro, mentre qui c’è uno strumento di uguale potenza su una montatura altazimutale computerizzata: potenza uguale ma al costo di 200 euro in più e senza la versatilità di una piccola montatura equatoriale (che ad esempio potrà essere usata come astroinseguitore per fare foto a grande campo togliendo il telescopio). Da tenere in mente che se osserviamo dalla città ci potremo dedicare solo a Luna, pianeti e qualche stella doppia: tutti oggetti molto facili da trovare a mano attraverso il cercatore.

Newton GSO da 150 mm su montatura EQ3 manuale: un ottimo inizio per il profondo cielo.
Se abitiamo sotto cieli molto scuri e/o abbiamo la possibilità, nonché l’intenzione, di trasferirci verso le Alpi o gli Appennini per fare osservazioni degli oggetti del cielo profondo, senza precluderci la possibilità di imparare a fare qualche foto, allora strumenti da 90-100 mm ci staranno stretti perché nebulose e galassie vogliono grandi diametri. In questo caso la configurazione ideale sarebbe quella di un telescopio newtoniano da 150 mm, proprio su montatura EQ3. Difficile salire con il diametro mantenendo la configurazione Newton, perché servirebbe una montatura più robusta, quindi costosa. In alternativa, però, uno Schmidt-Cassegrain da 150-200 mm, sulla stessa montatura, potrebbe essere un setup leggero e tuttofare, adatto sia per la città che per i cieli scuri. Il problema? Che costa più di un semplice Newton da 15 cm di diametro. In questi casi il puntamento automatico potrebbe essere utile per trovare con rapidità gli oggetti celesti. Se non vogliamo rinunciarci dobbiamo aggiongere i soliti 200-300 euro, a parità di diametro dello strumento e di montatura.

Un dobson da 200 mm è la scelta migliore per spazzolare nebulose, galassie e ammassi, a patto di avere un cielo buio.
Se disponiamo di cieli scuri e non siamo interessati alla fotografia a lunga posa, ma magari ci accontenteremo di qualche scatto alla Luna, allora via la montatura equatoriale, che spesso costa più del telescopio vero e proprio, e dirigiamoci verso le configurazioni Dobson: in pratica un tubo ottico in configurazione Newton (la più economica) che poggia su una spartana base in legno. Non potremo motorizzarla (almeno non con poco denaro) e non ci permetterà mai di fare foto a lunga posa come una montatura equatoriale (neanche se la motorizziamo!) ma per lo stesso costo avremo a disposizione uno strumento molto più potente dal punto di vista ottico. In questo caso un Dobson da 200 mm di diametro è uno strumento che sotto un cielo scuro ci farà già vedere cose meravigliose. Se vogliamo spendere meno possiamo considerare il fratello minore da 150 mm. Meglio non esagerare con il diametro oltre questo valore perché aumenterà il peso, l’ingombro e la difficoltà di gestire un telescopio alto quasi quanto noi.
Se siamo già determinati e vogliamo fare un acquisto una volta per tutte, allora le possibilità sono due:
- Montatura HEQ5, EQ6 o equivalenti Ioptron e Celestron, con GOTO, e uno Schmidt-Cassegrain da 200 mm (il classico C8, ad esempio) se vogliamo fare fotografie e buone osservazioni sia dei pianeti che del profondo cielo;
- Dobson da 10-12 pollici, di qualsiasi marca, eventualmente con GOTO, ma solo se potremo sfruttarlo sotto cieli scuri (e se riusciamo a trasportarlo!), se siamo interessati solo all’osservazione. Avere a disposizione uno strumento da più di 20 cm per fare osservazioni del cielo profondo ha senso solo se lo potremo portare sotto cieli non compromessi dall’inquinamento luminoso.
Qualsiasi sarà la vostra scelta, ricordate un paio di cose:
- L’astronomia è una disciplina “vecchio stampo” che va appresa, compresa ed esercitata con determinazione affinché possa regalarci molte gioie. Ci saranno sempre le difficoltà da affrontare: l’importante è non scoraggiarci;
- L’osservazione, attraverso qualsiasi strumento, all’inizio sarà traumatica. L’occhio non è abituato a guardare di notte da un foro grosso quanto il buco di una serratura e gli servirà molto tempo per abituarsi: allenatelo facendo pratica con il vostro primo telescopio;
- Non esiste strumento che ci farà vedere gli oggetti celesti come appaiono in fotografia. Il limite non è infatti il telescopio ma l’occhio umano. E a meno di non farci trapiantare un più performante occhio bionico, dovremo abituarci a capire che fotografia e osservazione sono due cose diverse. Quest’ultima è sicuramente meno spettacolare dal punto di vista estetico, ma riuscirà a entrare dritta nella nostra anima per l’immensa portata emotiva che nient’altro, se non l’immensità e l’incredibile bellezza dell’Universo, potrà regalarci.